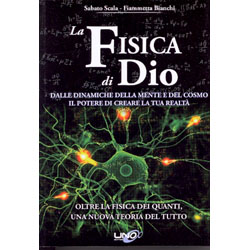Mi rendo conto che, con questo articolo, vado a rompere le uova nel paniere di molti professionisti del settore e amici, per cui nutro anche grande stima. Voglio però chiarire che, prima di tutto, l’ho scritto un po’ di mesi fa (quando la consulenza filosofica mi era estrane e, paradossalmente, la guardavo ancora con diffidenza), pubblicandolo solo recentemente; ma, soprattutto, questa mia riflessione è il frutto di ricerche che ho realizzato, da cui è emersa un’eclatante ostilità che trovo assurda, principalmente perchè considero che le discipline umanistiche, e le pratiche a cui queste danno seguito, dovrebbero collaborare. Si può leggere nel post, infatti, una sola critica alla categoria citata, per l’atteggiamento di chiusura che ha assunto, chiusura che essa stessa ha subito da parte dell’ordine dei medici, come con onestà intellettuale ha ammesso il dott. Migone, quando fece il suo ingresso nella storia. Il post è nato come un monito per ricordare soprattutto il rispetto reciproco che si deve avere per ogni percorso diverso, sia individuale che scientifico, che ogni sapere porta con sè. Continua a leggere
Filed under: filosofia | Tagged: agire, agorà, Albert Ellis, analisi esistenziale, analizzare, antica missione di senso, antichità, astronomia, autentico, blog, comunicativa, concorrenti sul mercato, conoscenza, convinzioni, coscienza di sè, cosmica, counselor filosofico, crescita, dialogo dell'anima, discipline umanistiche, domande, Dott. Paolo Migone, educazione dell'essere, ente, Epitteto, etica, Fabio Volo, farmaco, festival della filosofia, figura professionale, filosofi, filosofia, filosofia antica, filosofo schiavo, fisica, Francesco Sole, greco-romana medievale arabi, Heidegger, indagine, indagine filosofica, interdisciplinarità, introspezione, io, Ippocrate, Jules Evans, maieutica, maieuticamente, matematica, matrice discipline umanistiche, medici, mente, metafisica, motivazioni, ordine professionale, pedagogia, perdita di senso, persona, personal trainer, pharmakon, phronesis, politica, pragmatica, pratica educativa, pratica filosofica, problemi disagi, professione, profondità, psicanalisi, psicologia, psicologico, psicologo, psicoterapeuti, psicoterapia, qualità della vita, rapporto terapeutico, Rational-Emotive Therapy, relativismo, relazione col mondo, resilienza, ricerca, ricerca di senso, risposte emotive, saggezza, saggezza esistenziale, saggia inquietudine, sapienza, scientifiche, senso della vita, sociologia, Socrate, stile di vita, stili interpretativi, stoiche, storia della filosofia, studi accademici, tecniche adeguate, teorie filosofiche, terapia cognitivo-comportamentale, valore esistenziale, veleno, verità, versatilità, visioni della vita, vissuto esistenziale, vita | Leave a comment »